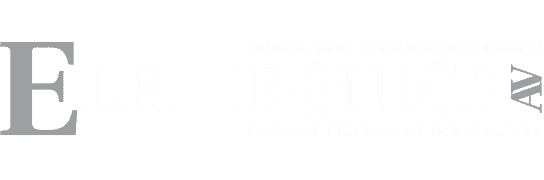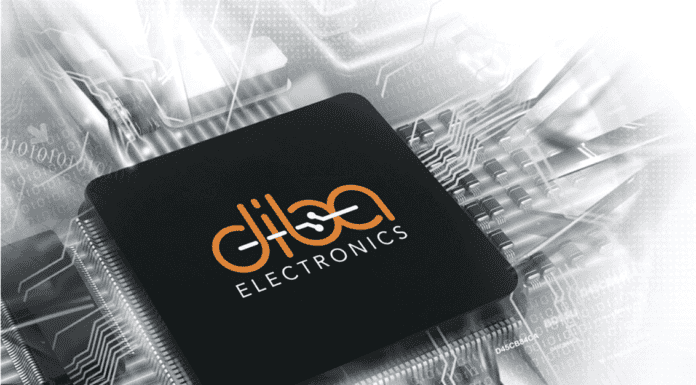La parità di genere torna ogni anno sulle prime pagine l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, ma il tema richiede un interesse costante, che deve passare anche attraverso il linguaggio. Proprio quest’ultimo rappresenta un asset fondamentale nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022, che stabilisce le linee guida sul sistema di gestione della parità di genere e prevede l’implementazione di specifici KPI relativi alle Politiche di Parità di Genere in tutte le organizzazioni.
“La Festa della Donna è un’importante occasione per riflettere sulle disuguaglianze ancora presenti nella società e per promuovere l’uguaglianza di genere. Questa festa ci ricorda che nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni, le donne continuano a lottare per ottenere gli stessi diritti e opportunità degli uomini in tutti gli ambiti della vita”, afferma Sabrina Zapperi, Responsabile Marketing e Comunicazione di TÜV Italia, uno dei soggetti abilitati a erogare la certificazione volontaria ottenibile secondo la norma UNI/PdR 125:2022, e Ambasciatrice italiana del Gruppo Women@TÜVSÜD.
Le parole contano
Il linguaggio ha grande importanza nel plasmare la società e nel definire l’identità di genere e può contribuire ad abbattere gli stereotipi, non rivestendo un’importanza solo semantica, ma anche e soprattutto storica, sociale e culturale. Il linguaggio condiziona il modo di pensare ed è infatti un mezzo fondamentale per trasmettere messaggi, idee, valori. Proprio per questo però veicola e rinforza anche pregiudizi e vecchi retaggi in grado di influenzare i nostri comportamenti e le relazioni sociali. Il linguaggio, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella creazione e nella diffusione degli stereotipi di genere, ma può anche essere un potente strumento per promuovere l’uguaglianza di genere e la diversità. Utilizzare un linguaggio inclusivo e rispettoso della diversità di genere può quindi contribuire a creare un ambiente più inclusivo e rispettoso delle differenze individuali.
I termini e le espressioni che utilizziamo nella comunicazione quotidiana possono influire sulla percezione di noi stessi e degli altri, così come sulla percezione della società in generale. Ad esempio, l’utilizzo di espressioni come “lavoro da uomo” o “lavoro da donna” può condizionare l’idea che si ha dei ruoli di genere e delle capacità delle persone in base al loro sesso.
L’espressione “sessismo linguistico” nasce negli Stati Uniti tra gli anni ‘60 e ‘70, quando è stata riconosciuta una forte discriminazione nel modo di raffigurare anche linguisticamente la donna rispetto all’uomo. Nel 1987 la discussione viene affrontata anche in Italia grazie a uno scritto rivoluzionario, “Il sessismo nella lingua italiana” di Alma Sabatini, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta a stabilire una parità fra i sessi grazie al riconoscimento delle differenze di genere (inteso come gender all’anglosassone).
Utilizzare un linguaggio inclusivo – parlando, ad esempio, di diritti della persona al posto di diritti dell’uomo – contribuisce quindi a creare un modo più equo di rappresentare la realtà, arrivando così a influenzarla positivamente. Le parole che scegliamo di usare condizionano nel bene e nel male la nostra capacità di creare relazioni. Il linguaggio inclusivo si basa su empatia e scambio e ha un impatto molto positivo sulla sfera emotiva delle persone, anche in ambito lavorativo.
Ma com’è un linguaggio inclusivo in concreto? Sicuramente rispettoso ma anche preciso e accurato. Non è una questione secondaria poiché contribuisce in modo significativo a creare una cultura e un ambiente più sereno e aperto, in cui le persone possono sentirsi più a proprio agio.
“Le parole permettono di includere ed escludere e sensibilizzare verso un linguaggio in grado di favorire la condivisione rappresenta quindi un’opportunità di crescita per tutti, non solo per le aziende”, conclude Zapperi. “Quindi, facciamo caso alle parole che usiamo sia in ufficio che altrove: ad esempio non definiamo un uomo con una laurea dottore e una donna con lo stesso titolo signora oppure non chiamiamo una donna per nome e un uomo per cognome. Perché i fatti contano. Ma contano anche le parole, tutte, anche le nostre!”
Potrebbe interessarti anche:
Tüv Süd aggiorna il portale dedicato al recruiting