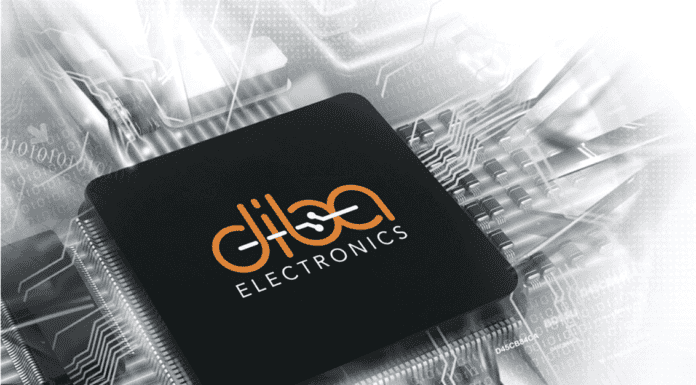di Alan Friedman | Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sei crisi diverse, tutte insieme. Che l’attuale inquilino della Casa Bianca voglia ammetterlo o no, c’è una crisi sanitaria, con una pandemia in corso. Donald Trump insiste a dire che “si fanno troppi test” e prontamente spiega: “Se si facessero meno tamponi il numero dei casi sarebbe più basso”. Ovvero: un indice di casi un po’ più rassicurante sulla carta si tradurrebbe in un miglioramento dei sondaggi contro Joe Biden. O almeno così crede. E non cerca nemmeno più di nasconderlo.
La crisi sanitaria
Il Covid-19 si sta ancora diffondendo in svariati Stati governati da repubblicani, come la Florida o il Sud Carolina o l’Arizona o l’Oklahoma, dove i governatori di estrema destra hanno riaperto troppo presto. Ve lo immaginate cosa sarebbe successo se l’Italia avesse permesso a bar e ristoranti di riprendere le attività alla fine di aprile? Ecco, più o meno è ciò che hanno fatto questi Stati, con l’applauso di Trump. Il prezzo che adesso devono pagare è terribile. Eppure non richiuderanno. Trump sbeffeggia e nega la minaccia del Coronavirus, nega la scienza, innalzando la bandiera del machismo per esaltare i suoi follower, e molti repubblicani si sono prontamente accodati. Il dottor Anthony Fauci, la voce della ragione, l’esperto di medicina più rispettato d’America, è stato ridotto al silenzio assoluto, o quasi. Trump l’ha relegato in secondo piano, lo tiene lontano dalla Casa Bianca. Il dottor Fauci dice solo la verità, mette in guardia dai pericoli di una seconda ondata in autunno, dichiara che riaperture premature faranno schizzare in alto il numero dei casi. Ma nessuna di queste verità fa piacere a The Donald. E quindi Fauci non si vede più. O si vede poco.
La crisi sociale
Nell’America di Trump la crisi non è solo sanitaria. C’è molto di più. Quella che stiamo vivendo è anche una gigantesca crisi sociale, uno sconvolgimento nazionale, una serie di proteste che non hanno precedenti, molto diverse da quelle degli anni Sessanta. Un periodo di disordini, inquietudine, razzismo e violenza dilagante nelle strade. Purtroppo in molti Stati le forze dell’ordine, i tutori della legalità, ovvero i poliziotti, sono parte del problema più che della soluzione. La componente razziale della questione è stata aggravata dalla retorica incendiaria di un presidente che troppo spesso, quando prende la parola, ricorda un qualsiasi suprematista bianco. Trump non ha mostrato la minima empatia verso George Floyd o il movimento di “Black Lives Matter”. Anzi, ha fatto suo il punto di vista dei suprematisti. Il punto di vista della polizia. Mentre rabberciava una risposta raffazzonata all’emergenza Covid, si è affidato a Twitter per portare avanti la sua tattica imperniata sul “distrai e dividi” e per soffiare sulle pulsioni razziste, nazionaliste e anti immigrati di certe componenti della sua base elettorale. Il ragionamento è chiaro: dato che non vincerà mai nella New York liberal, tanto vale ricominciare a fare la corte ai voti del Ku Klux Klan. Mai un presidente americano ha diviso così tanto la sua nazione. Mai, nell’intera storia statunitense. E mai, prima di Donald Trump, un presidente si è comportato in modo così simile a un caudillo. In un’epoca di violente proteste, di caos e crisi sociale, la soluzione di Donald Trump è stata schierare l’esercito contro il suo stesso popolo. Per le strade di Washington sciamano militari e para militari in assetto antisommossa armati di mitra. Per farsi riprendere con una Bibbia in mano di fronte a una chiesa ha scatenato un violento attacco ai danni di manifestati pacifici a Lafayette Square. Un momento buio della sua discesa verso l’autoritarismo. Ora come ora, è virtualmente la prima causa della crisi sociale in corso: perché è lui che l’alimenta, giorno dopo giorno, senza sosta. Fa tutto parte della sua strategia elettorale. Dividere, seminare discordia. La vecchia ricetta di Steve Bannon.
La crisi dei diritti civili
Oltre alla crisi sanitaria e a quella sociale, l’America subisce oggi anche una crisi di diritti civili: il governo sta cercando di cancellare anni di battaglie di minoranze, donne, gay e immigrati. Il suo appello per rendere illegale l’aborto è stato accolto in più di 15 Stati. Nella sua corsa verso una democrazia illiberale Trump non ha esitato a utilizzare tribunali, giudici, cause legali e decreti, che hanno minato e svuotato i diritti civili delle donne, della comunità Lgbt e delle minoranze etniche. Ha rinforzato la vecchia politica razzista della voter suppression: in molti Stati repubblicani, e in alcuni di quelli chiave in cui Trump ha un assoluto bisogno di vincere, le autorità locali non dispiegano personale sufficiente per consentire alla gente di votare senza intoppi durante l’Election Day. La macchina organizzativa si inceppa di continuo, gli elettori latino americani e neri sono costretti a venire a capo di criteri di ammissibilità sempre più stringenti e complicati, allo scopo di scoraggiarli e ridurre la loro affluenza (cosa che presumibilmente si risolverebbe in uno svantaggio per i democratici). Allo stesso tempo Trump sta cercando di mandare in bancarotta lo U.S. Post Office e continua ad attaccare il diritto di voto per posta, nella convinzione che favorisca i democratici. Pur di scoraggiare l’elettorato ostile è pronto a ricorrere a misure estreme che minacciano le nostre pratiche democratiche e persino lo stesso diritto di voto.
La crisi del sistema giudiziario
Quella incentrata sui diritti civili è solo una parte di una più ampia crisi del sistema giudiziario. Un problema serio per la nostra democrazia, che dovrebbe essere fondata su un sistema di pesi e contrappesi che garantisca il bilanciamento tra i tre poteri: giudiziario, esecutivo e legislativo. Ma Trump ha avuto come mentore Roy Cohn, ex consigliere delle famiglie mafiosi newyorchesi e protagonista di primo piano dell’era della caccia alle streghe lanciata da Joseph McCarthy contro i presunti comunisti a Hollywood. Perciò, quando qualcuno indaga su Trump, lui lo licenzia. La tendenza è questa. Ha fatto così con Jim Comey, capo dell’Fbi, e adesso ha passato il testimone a William Barr. Trump usa il ministro della Giustizia come se fosse il suo avvocato personale. La crisi del sistema giudiziario è giunta al culmine il 19 giugno, quando Barr ha licenziato il procuratore generale di New York, Geoffrey Berman – e solo perché, in tutta evidenza, Trump gli ha ordinato di sbarazzarsene. Berman stava indagando sul presidente e sui suoi banchieri, sui trust familiari, accordi fiscali e assicurativi. Berman indagava anche sull’amico e avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani. La legge proibisce al presidente e al ministro della Giustizia di licenziare per motivi politici pubblici ministeri che osano indagare familiari o persone vicine al presidente. Eppure è esattamente ciò che sta succedendo.
La crisi economica
Ma com’è ovvio c’è anche una crisi economica in corso, e secondo molti potrebbe essere questa la più importante crisi di tutte. Stiamo entrando in un periodo di recupero irregolare e ondivago da una profonda recessione: in altre parole dobbiamo superare le scorie del lockdown imposto dal Covid. Anche se dal punto di vista economico ci riprenderemo nell’arco di un anno o due, ci sono ancora decine di milioni di americani senza lavoro, e milioni di piccole imprese a rischio. Qualsiasi misura economica che venga introdotta da adesso a novembre avrà un’impronta politica ed elettorale molto forte. È chiaro il tentativo di Trump di stampare moneta per comprare voti, che si tratti di miliardi e miliardi di dollari di “helicopter money” o altre iniziative di spesa pubblica. L’economia americana, come quella europea, sarà in sofferenza nel 2020, e magari ci vorrà quasi un biennio per tornare ai livelli di Pil del 2019. Eppure a Wall Street l’ottimismo vola sulle ali dell’entusiasmo, e il Dow Jones certe volte sembra anche troppo esuberante. C’è da aspettarsi una forte volatilità, da adesso fino al periodo immediatamente successivo alle elezioni del 3 novembre.
La crisi nella politica estera
C’è inoltre una crisi di politica estera, anch’essa frutto delle azioni del nostro presidente, che si è ritirato o ha attaccato quasi tutte le istituzioni multilaterali di cui gli Usa facevano parte, dall’Oms agli accordi di Parigi sul clima, per finire con la World Trade Organization, la Nato e la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite. Gli Usa hanno abdicato alla loro leadership globale e Trump ha scagliato attacchi velenosi ai suoi più stretti alleati in Europa. La scelta trumpiana ha avuto radicali conseguenze sul piano geopolitico: la Cina ha accelerato la sua corsa verso lo status di nuova superpotenza del ventunesimo secolo, e Vladimir Putin ha avuto il via libera per fare ciò che vuole, dove vuole e quando vuole. Er- dogan ha intenzione di chiudere i conti con i curdi? Non è un problema. L’America si ritira dalla Siria, e la Russia occupa le sue vecchie basi. Israele può annettersi altri territori palestinesi. Modi, in India, può aprire il fuoco contro i pachistani al confine. Bolsonaro può tollerare un genocidio in Amazzonia, e nessuno alza un dito.
Le conseguenze delle crisi
Le conseguenze sono in gran parte negative per l’Europa e per il resto del mondo. La ripresa economica sarà più lenta se Trump verrà rieletto. Il mondo sarà un posto più cupo, più oscuro. Ha legittimato il razzismo sul fronte interno, come legittimerà le dittature in ogni angolo del globo. E a quel punto il flashback agli anni Venti potrebbe diventare spaventosamente realistico. Se invece Biden vincesse a novembre ci potrebbe essere un gran sollievo collettivo nel mondo e la borsa potrebbe non crollare e ci potrebbe essere la possibilità che l’America tornasse ad essere l’America. Anche questo è uno scenario possibile.
La versione integrale dell’articolo
è stata pubblicata sul numero 3 di Elettronica AV
Chi è Alan Friedman
 Giornalista, conduttore televisivo, scrittore ed esperto di economia, è stato inviato dell’International Herald Tribune e editorialista del Wall Street Journal. Ha iniziato la sua carriera come collaboratore dell’amministrazione del Presidente Carter, ha ideato e condotto vari programmi Rai, ha lavorato all’ideazione e al lancio di Rainews24 e nel 2003 ha collaborato con Rupert Murdoch alla creazione di SkyTG 24. Nel corso della sua carriera giornalistica al Financial Times di Londra, Alan Friedman è stato insignito per ben quattro volte del British Press Award. Tra i suoi scoop più celebri la scoperta dello scandalo Iraq-gate, la vendita di armi a Saddam Hussein grazie ai finanziamenti illeciti effettuati anche tramite la Bnl, che hanno coinvolto la Cia. È autore di nove best-seller, compresa la sua ultima fatica “Questa non è l’Italia” edito da Newton Compton.
Giornalista, conduttore televisivo, scrittore ed esperto di economia, è stato inviato dell’International Herald Tribune e editorialista del Wall Street Journal. Ha iniziato la sua carriera come collaboratore dell’amministrazione del Presidente Carter, ha ideato e condotto vari programmi Rai, ha lavorato all’ideazione e al lancio di Rainews24 e nel 2003 ha collaborato con Rupert Murdoch alla creazione di SkyTG 24. Nel corso della sua carriera giornalistica al Financial Times di Londra, Alan Friedman è stato insignito per ben quattro volte del British Press Award. Tra i suoi scoop più celebri la scoperta dello scandalo Iraq-gate, la vendita di armi a Saddam Hussein grazie ai finanziamenti illeciti effettuati anche tramite la Bnl, che hanno coinvolto la Cia. È autore di nove best-seller, compresa la sua ultima fatica “Questa non è l’Italia” edito da Newton Compton.