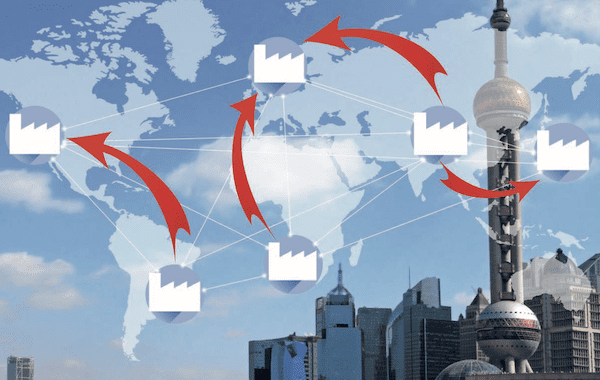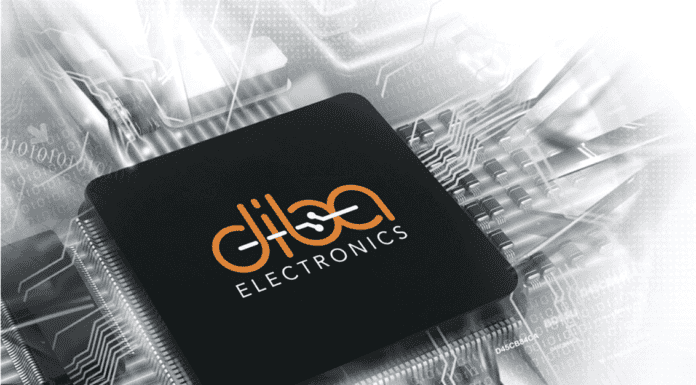di Alan Friedman |
Se volgiamo lo sguardo ai tre anni che abbiamo alle spalle, dall’inizio del 2020 ai primi mesi del 2023, possiamo tracciare la drammatica traiettoria che ha intrapreso quel fenomeno conosciuto come “globalizzazione”. Prima del Covid avevamo vissuto un trentennio di crescente interdipendenza economica. Fin dagli anni Novanta i nostri dirigenti d’azienda hanno continuato a magnificare e sfruttare i vantaggi che la globalizzazione assicurava alle complesse catene di approvvigionamento globali, permettendo processi di logistica just-in-time. Bill Clinton e il suo Segretario al Tesoro Bob Rubin erano i sommi sacerdoti del libero commercio e della globalizzazione, insieme agli altri membri della élite di Davos. Sembrava che il pianeta diventasse sempre più piccolo, nel mirino c’erano zone commerciali sempre più estese, sempre più grandi. Era eccitante. La Cina è entrata nell’Organizzazione mondiale del commercio; pareva che il mondo intero prosperasse. E se determinati settori manifatturieri strategici, come quello dei semiconduttori o delle batterie al litio, finivano in gran parte nelle mani di Cina, Taiwan, Corea del Sud e Giappone, nessuno se ne accorgeva, o comunque, nessuno se ne preoccupava.
Il Covid e la supply chain
Poi nel 2020 è arrivato il Covid, e il virus si è portato dietro radicali sconvolgimenti che hanno travolto numerose catene di approvvigionamento, tra blocchi, interruzioni, sospensioni e parziali riprese. Nel frattempo, Donald Trump ha lanciato una guerra commerciale contro la Cina, che il suo successore non ha fatto altro che esacerbare, in una escalation sottolineata da nuove misure restrittive che andavano contro il libero commercio. Poi, nel febbraio del 2022, è arrivata la guerra del signor Putin: l’invasione dell’Ucraina ha portato nuovo caos, e ancora una volta ha costretto il mondo a ripensare le fonti da cui ottiene materie prime, prodotti chiave, tecnologie avanzate ed energia. E il conflitto in Ucraina comporta altre sfide per i network delle catene di approvvigionamento globali. La nascita di governi nazionalisti in diversi parti di Europa ha già messo in luce un protezionismo montante che tende a favorire le ipotesi di “reshoring” strategico. La fuga dalla dipendenza dal gas russo ha rivelato le vulnerabilità dell’Europa, ma allo stesso tempo ne ha evidenziato anche la capacità di essere flessibile, in caso di necessità. Perciò ora l’obiettivo è raggiungere una qualche forma di parziale autonomia, mentre il mondo sperimenta quella che si potrebbe ragionevolmente definire una “parziale deglobalizzazione”.
Le mosse degli americani
Purtroppo, l’amministrazione Biden ha scelto di aprire nuovi fronti con la Cina senza alleviare le barriere commerciali erette da Donald Trump. La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata un errore. Meno americani parlano di Taiwan, più essa sarà al sicuro dall’invasione. Ma nel circo della politica interna statunitense dare addosso alla Cina è un gioco che spesso paga dividendi elettorali per i membri del Congresso. Il programma di incentivi fiscali da 52 miliardi di dollari messo in piedi di recente dall’amministrazione Biden per incoraggiare le aziende a investire in fabbriche di semiconduttori in America va dunque letto alla luce della volontà di rendersi autosufficienti. Alcune compagnie taiwanesi, come anche altre dall’Eu- ropa e dall’Asia, hanno scelto di usufruire dei crediti fiscali americani e di investire decine di miliardi di dollari. Tutto compreso, le iniziative legislative di Biden potrebbero stimolare in- vestimenti di capitali per centinaia di miliardi di dollari. Ma, nonostante tutti questi sforzi, gli Stati Uniti resteranno comunque dipendenti dai fornitori esteri, e ci vorrà un decennio o anche più perché le nuove capacità manifatturiere arrivino a pieno regime. Allo stesso tempo il governo americano ha introdotto severi controlli sulle esportazioni di prodotti di informatica avanzata e di semiconduttori verso la Repubblica popolare. Quella tra Usa e Cina è una corsa, una gara: il che significa che vedremo altre restrizioni, nuove escalation su entrambi i fronti. Anche se tali misure vanno contro gli interessi commerciali di entrambi.
Verso una parziale deglobalizzazione
Il sentiero che porta alla parziale deglobalizzazione si snoda anche in funzione delle relazioni politiche tra Washington e Pechino. L’ostilità sui palloni spia, le differenze sui diritti umani, oltre alla necessità da parte del signor Biden di dare un’impressione di salda durezza nei confronti della Cina nel periodo che precede la dichiarazione ufficiale della sua nuova candidatura alla Casa Bianca, sono tutti fattori che contribuiranno a rendere impervia la strada che ci si apre davanti. Le conseguenze geo-economiche e geo-politiche di queste turbolenze si faranno sentire su vasta scala. In alcuni casi saranno permanenti. Questo non significa che il libero commercio sia morto. E neppure che il protezionismo sia destinato a trionfare, o che il trend della deglobalizzazione arriverà necessariamente a bloccare e smantellare le catene di approvvigionamento al livello che molti temono. Si tratta pur sempre di un processo parziale.
Ma lo spettro della deglobalizzazione, fosse anche solo parziale, è qui, è in mezzo a noi. Si sta manifestando. E non è una buona notizia.
Potrebbe interessarti anche: