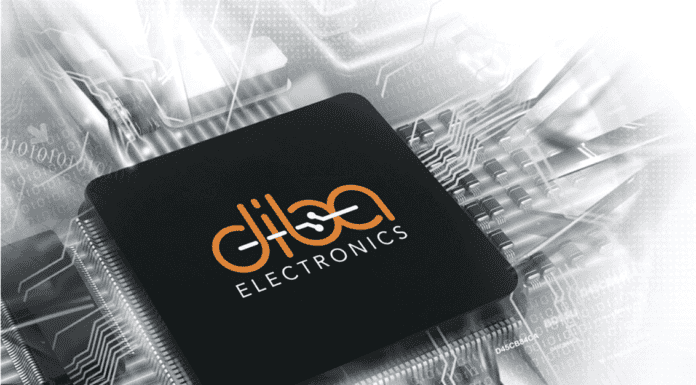di Virna Bottarelli | Da un anno e mezzo in Italia, e non solo, ci interroghiamo su come la pandemia abbia cambiato le nostre vite, su quanto siamo migliorati o peggiorati, sull’efficacia o meno delle misure adottate dalle istituzioni per contrastare la crisi sanitaria e le sue ricadute economiche. Le tante opinioni che si stratificano l’una sull’altra non sempre riescono a dare conto della complessità del nostro tempo. Un tempo iniziato prima di una pandemia che, sì ha sconvolto alcune nostre certezze, ma ha anche, più semplicemente, dato delle conferme. Una su tutte, come dice Carlo Alberto Carnevale Maffè, è, senza dubbio, quella di “far parte di un unico, grande mercato”.
L’articolo integrale è pubblicato sul numero 10 di Elettronica AV

C’è una lezione che possiamo trarre dall’impatto che la pandemia ha avuto sul Paese?
Chi paventava un ritorno all’economia “sovranista” è stato smentito dall’evidenza dell’interdipendenza strutturale dei processi economici: ecco perché l’isolazionismo, in economia, ha oggi una veste puramente ideologica, che non trova riscontro nella realtà. La pandemia riguarda tutti e non è pensabile affrontarla a un livello esclusivamente locale, regionale o nazionale; occorrono strategie sanitarie a livello europeo e globale. Di questo la politica internazionale si è resa conto, prendendo atto che le singole risorse nazionali non possono affrontare una crisi che ha un livello tale di interdipendenza: non si tratta solo di elargire dei fondi a un Paese o a un altro, ma di un’Europa che, con il Recovery Fund, si è presa la responsabilità, per la prima volta nella storia, di emettere debito. Le illusioni di separatismo economico, in questi ultimi due anni, si sono rivelate per quello che erano: mistificazioni o manipolazioni a fini politici.
A proposito di Recovery Fund: basterà un enorme flusso di denaro per migliorare la competitività delle nostre imprese?
Innanzitutto, dobbiamo chiarire che il flusso di denaro non è enorme. Stiamo parlando di risorse per 32 miliardi all’anno, l’equivalente dell’1,9% del PIL, del 3% della spesa pubblica o, ancora, del 10% dei volumi medi degli investimenti fatti in Italia. Per questo, la valenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che l’UE ha approvato è più istituzionale che finanziaria: l’Europa sta mettendo in comune uno sforzo di transizione ecologica e digitale, erogando risorse per finalità specifiche, riconducibili esclusivamente agli obiettivi della transizione. E le risorse sono una sorta di ricompensa per delle riforme che, ancora, devono essere fatte: su tutte, quella della concorrenza, della giustizia civile, della PA, della scuola e delle competenze. Se non si porteranno a termine le riforme, le risorse non arriveranno. Il patto è molto chiaro.
Recentemente ha detto: “Ripartire non vuol dire che si torna a prima”. Che cosa va cambiato e come?
Il cambiamento è già avvenuto, perché nulla è tornato come prima. Il lavoro, ad esempio, in tutti i settori, dalla produzione, al commercio, ai servizi, è cambiato: le imprese hanno imparato a vendere senza partecipare alle fiere, a fare manutenzione a distanza, a installare macchinari usando le webcam. Credo si debba trovare ora un punto di equilibrio che, in termini economici, di impatto ambientale e di stress psico-fisico delle persone, può rivelarsi positivo in tutti i settori. E in questo nuovo equilibrio l’elettronica ha un ruolo centrale. La stessa scelta dell’Europa di andare verso la transizione ecologica e digitale produrrà un aumento della domanda di software ed elettronica: la trasformazione della mobilità, dei trasporti e del settore energetico ci dice che non torneremo al punto di prima e che per l’elettronica, l’automazione, la robotica, la tecnologia in genere si sta aprendo una grande finestra di opportunità. Proprio l’industria elettronica, tuttavia, ha commesso l’errore di non avere colto in tempo la portata del cambiamento in atto: essa stessa è responsabile dello shortage dei chip, perché non ha capito quanto sarebbe stata determinante e non ha saputo anticipare l’aumento della domanda di hardware e software.
Parlando di cambiamento, è realistico pensare di riportare in Italia quelle produzioni che negli anni sono state delocalizzate? Oppure sarebbe meglio per il nostro Paese puntare a sviluppare un’economia orientata ai servizi?
La pandemia ha colpito più il settore dei servizi, dal turismo ai trasporti, che non il settore industriale. Quest’ultimo ha reagito, sia in termini di definizione dei protocolli di sicurezza che in termini di capacità produttiva, molto meglio e in tempi brevi, dando un segnale importante di resilienza. Il nostro è un Paese con un manifatturiero di qualità e orientato all’export, un bene in un’economia interdipendente, mentre il nostro terziario – banche, trasporti, servizi professionali – non è competitivo, non esporta. Certo, abbiamo, come frutto di una “dote naturale”, il turismo, che però non è ben valorizzato per mancanza di coordinamento e di infrastrutture adeguate: non fa sorridere pensare che le più importanti piattaforme di prenotazione, nelle quali le nostre strutture ricettive sono presenti in modo massiccio, siano state inventate da olandesi e americani? Il settore manifatturiero deve rimanere centrale per la nostra economia, ma non credo il nostro Paese potrà ospitare nuove produzioni che richiedono grandi investimenti o, meglio, che necessitano di un capitalismo manageriale e finanziario, perché in Italia questo capitalismo è assente. Il livello degli investimenti esteri green field sul territorio nazionale è il più basso d’Europa, siamo al 58° posto nell’indice Doing Business e i capitali che entrano in Italia, tra i 25 e i 30 miliardi all’anno, sono in gran parte destinati ad acquisizioni: pensiamo alle diverse grandi imprese private che da tempo non sono più italiane, da Fiat a Luxottica a Lottomatica. Gli investimenti, del resto, si fanno laddove ci sono le condizioni per farli fruttare e per ora in Italia queste condizioni non ci sono. Quando si dice di voler penalizzare chi delocalizza, focalizzandosi su settori che producono beni a basso contenuto tecnologico, si commette un errore, perché non è sulle tecnologie mature che dobbiamo puntare: queste possono ormai essere sviluppate ovunque nel mondo. Dovremmo attrarre investimenti nei settori che stanno crescendo a doppia cifra. E poi, non si dica che i capitali non arrivano perché abbiamo un costo del lavoro elevato: gli investitori non ci scelgono perché abbiamo una produttività del lavoro che non cresce da anni, è un discorso diverso. Non aspettatevi, quindi, in futuro, grandi investimenti, né esteri, per i motivi di cui sopra, né italiani, perché gli imprenditori di casa nostra non investono grandi capitali in nuove tecnologie che richiedono miliardi. Sono magari propensi a investire milioni in tanti progetti di dimensioni minori, ma non a muovere somme ingenti in grandi iniziative di innovazione tecnologica.
In tema di innovazione, i dati su incubatori e startup in Italia indicano una crescita del comparto negli ultimi anni, ma i numeri rimangono esigui se confrontati con gli altri Paesi europei. Perché?
Il Decreto Passera del 2012 ha creato le condizioni per uno sviluppo del settore, che è effettivamente cresciuto, ma ad oggi non investiamo abbastanza. Posso portare la mia esperienza personale di amministratore indipendente di United Ventures, una delle realtà più grandi in Italia, che però ha un volume di business molto ridotto rispetto ai competitor europei. Sebbene nel nostro Paese si stimi una liquidità di 1.800 miliardi di euro, la mentalità imprenditoriale è solitamente di matrice padronale e la mobilità della professionalità scientifica è molto bassa. Questo non significa che non produciamo ottimi ingegneri e ricercatori sui quali investire, anzi. Il problema è che, una volta formati, li esportiamo in modo massiccio: i nostri profili migliori scelgono di lavorare all’estero perché in Italia il salary premium delle professioni tecniche è tra i più bassi d’Europa. È di nuovo un problema di mentalità: il piccolo-medio imprenditore spesso non fa entrare in azienda l’innovatore radicale perché non vuole affrontare cambiamenti radicali. Ecco, con un capitalismo così resistente, segnale di un Paese che non riesce ad accettare la modernità, è difficile fare davvero innovazione e anche i giovani sui quali investiamo con il venture capital spesso scelgono di aprire le proprie attività all’estero.
Torniamo allora al punto di partenza: dovremmo capire, una volta per tutte, di essere parte di un unico, grande mercato…
La tendenza dei giovani professionisti di lasciare l’Italia conferma che, per fortuna, il mercato del lavoro, e quello finanziario, sono europei. Per questo dobbiamo cambiare ottica: parlare di economia nazionale senza tenere conto delle interdipendenze di cui abbiamo già detto non ha senso. Dobbiamo oramai vedere la nostra economia come la regione italiana dell’economia europea. E, poi, riflettiamo sul fatto che le grandi capitalizzazioni degli ultimi dieci anni sono il frutto degli investimenti in venture capital del decennio precedente: questo significa che hanno successo gli investimenti fatti seguendo una visione di mercato a lungo termine e globale, che guarda cioè al mondo. È una visione che deve valere anche per il nostro Paese: o l’Italia va nel mondo, o non va da nessuna parte.
L’articolo integrale è pubblicato sul numero 10 di Elettronica AV